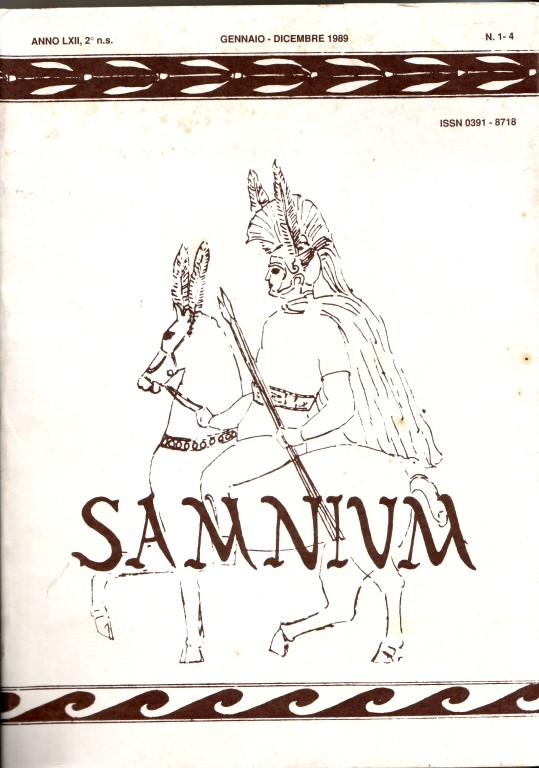 TRATTO DA “SAMNIUM” ANNO LXII NUM 1-4 -gennaio dicembre 1989-Benevento-
TRATTO DA “SAMNIUM” ANNO LXII NUM 1-4 -gennaio dicembre 1989-Benevento-
DA PAG. 5 A 14
Alfredo Zazo – Conferenza del 12 dicembre 1960
SANNIO
Ringrazio il gentile presentatore per le cortesi espressioni che mi ha voluto rivolgere ed esprimo il mio grato ringraziamento anche ai convenuti che mi onorano della loro presenza e ai soci di questo Circolo per avermi invitato a sfiorare un tema legato al nome del Sodalizio, le vicende del Sannio. Nome, quest’ultimo, che per settanta anni fu la costante preoccupazione di Roma se essa nel Sannio, vide il rivale che mirava ad unificare il Mezzogiorno della Penisola sotto il simbolo vigoroso del suo toro egemonico e l’egida del suo linguaggio e quindi della sua civiltà; di Roma che più tardi, per bocca di un suo dittatore, dovrà dire di non sentirsi sicura, finché il nome sannita non fosse sparito per sempre.
In un imprecisabile periodo di tempo, ma certo nel V sec. a.C., le tribù sannite sciamano dalle sedi, nella primavera, sacra al dio della guerra. Avevano atteso il muggire dei fiumi, gonfi delle disciolte nevi, e il vento fresco ed incitatore dei gioghi montani. Più, e oltre il prepotente istinto che spinge gli uomini all’asservimento dello spazio, incalza le tribù esuberanti di nati, incalza le già fiorite adolescenze, il bisogno di nuove terre. Vanno dal centro dell’Appennino verso i piani ubertosi, verso i pascoli pingui, dove le attende la lotta, la vittoria, la vita; vanno precedute da un toro, da un lupo, da un picchio. Sull’impervio cammino, sorvola Mavors, già nume tutelare delle serene opere campestri, ora torvo dio della guerra.
Il dilatarsi dell’espansione etrusca, la pressione umbra nell’Appennino centrale per il probabile rigurgito di masse illiriche discese dalle Alpi orientali o approdate dal mare, determinano questo movimento di popolazioni e costringono i Sanniti – lontano ceppo dei Sabini – a discendere verso il sud della Penisola. Occupato il Matese, antico Tifernus, il monte degli elci, i sopravvenuti ne fanno centro di una barriera difensiva con quattro città principali da essi fondate poste ai quattro aditi del massiccio: Boviano, Isernia, Alife, e Telesia. Poi dilagano nel piano. Si impadroniscono di Capua e di Cuma, annientano le propaggini etrusche, si espandono fra il Volturno e il Vesuvio che conserva il suo nome sannita di terra ardente. La regione allora, da essi, fu chiamata Campania. Ben presto dettero prova di un’intensa vitalità, consolidando le loro conquiste dal fiume Sangro (Appennino abruzzese), alla valle dell’Ofanto. Conosciamo fin da epoca lontana, le loro principali tribù: quella dei Caraceni nella valle del Sangro con capitale Alfedena; dei Pentri, sui due versanti del Matese con capitale Boiano e le città di Isernia, Venafro, Pietrabbondante, Trivento, Sepino, Alife, Aquilonia; dei Caudini, su uno dei versanti del Taburno e nelle valli del Sabato e del Calore con Caudium, Maloento e Telese; degli Irpini, di là dal Taburno, nelle valli superiori dei due fiumi ora ricordati, con le città Avellino, Conza, Eclano e Lacedonia, tribù tutte contenute nella loro massima parte, nelle attuali tre province di Campobasso, Benevento e Avellino. Un ramo, infine, dei Sanniti Irpini, si stanziò nella regione compresa fra le sorgenti del Sele e del Bradano, prendendo da un termine greco il nome di Lucani, cioè popolo dei Lupi. L’apparente, strano appellativo, ci riporta ad una vetusta tradizione sannita, tradizione comune anche a popolazioni celtiche e germaniche. Lo storico e geografo greco Strabone, vissuto intorno al I secolo, ci dice e non lui soltanto, che i Sabini guerreggiando con gli Umbri, fecero voto di consacrare a Marte tutto quanto fosse nato nell’anno. Avendo vinto, mantennero solo in parte la promessa, perché occorreva offrire al dio della guerra anche i figliuoli. Giunti questi all’età virile, preceduti da un Toro sacro a Marte, invasero le terre degli Osci e con quel nome fondarono la città di Bovianum, che fu uno dei più importanti centri religiosi della Confederazione Sannita. Gli Irpini, sciamarono anch’essi, preceduti dall’hirpus (lupo) e infine i Piceni. seguendo il volo del picchio, uccello che si riteneva dotato di virtù profetiche. Non è esatto, a questo proposito, l’opinione di qualche studioso il quale afferma che i Sanniti fossero in uno stato pressoché selvaggio, quando nella seconda metà del V secolo discesero nella Campania. Prima del IV secolo non ebbero – è vero – moneta nazionale, ma non l’ebbero allora neppure i Romani, e quando no si avvalsero di moneta straniera, adoperarono la permuta e il baratto,con i quali mezzi primitivi, commerciarono con le ricche ed evolute popolazioni della Campania e dell’Apulia.
D’indole guerriera (i Tarentini particolarmente reclutavano fra i sanniti, i soldati mercenari) erano anche laboriosi agricoltori. La popolazione viveva sparsa nelle campagne, tutta dedita nel periodo di pace, alle opere campestri, sicché i Romani nella lunga lotta che sostennero lungo il Sannio, pensarono sopra tutto a devastare e a disertare le zone agricole. La terra era estesamente coltivata e sapientemente concimata e tornava alla comunità quando per un certo tempo era stata abbandonata dal coltivatore. Sappiamo pure che i giovanetti erano allevati con rigidi costumi e faticosi esercizi; guidavano le greggi e l’aratro e al cenno delle madri severe, maneggiavano la scure per procurare il legno necessario ai bisogni familiari. Aspri, quindi, ma non rozzi, i Sanniti avevano modificata la loro civiltà originaria, al contatto di quella etrusca e in seguito della civiltà greca che permeava le popolazioni Osche del Mezzogiorno della Penisola. Dagli Etruschi essi avevano appreso la lavorazione dei metalli e la costruzione di quelle armi che i capi usavano ageminate d’oro e d’argento. Caratteristico lo scudo largo e piano in alto, per poter coprire la parte superiore del corpo e lasciare liberi i movimenti della testa, e ristretto nella parte inferiore, per renderlo facilmente maneggiabile. Adoperavano inoltre, elmi piumati e maglie di bronzo e per difendere il lato sinistro del corpo, piastre metalliche e schinieri alla sola gamba sinistra.
La cavalleria – anche se fu imitazione degli ordinamenti equestri di Taranto o di altre città della Magna Grecia – aveva molto peso nella costituzione dell’esercito Sannita e privilegi godevano coloro che possedevano o potevano mantenere un cavallo. In guerra eleggevano un supremo comandante: l’embratur. Scarsi i proletari e gli schiavi e questi ultimi dividevano con i liberi, le opere della pastorizia e dell’agricoltura. Se manca una vera letteratura, sia pure di contenuto religioso, nei monumenti residuali ritrovati su un vasto territorio da Alfedena a Pompei, la lingua neo-sannita appare sempre uniforme ed è questo indizio di una lingua assai ferma nell’uso ufficiale, imposta da un popolo già civile e già pervenuto a un tipo fisso di favella letteraria, buona a diffondersi e a tramandarsi, senza alterarsi. Vi fu certo un periodo in cui l’idioma sannitico rivaleggiava col greco nell’Italia meridionale, e il latino ebbe poi a lottare lungamente per smontare il sannitico.
La comune discendenza dei Sabini e dei Sanniti, fece sì che questi ultimi fossero accomunati nel culto. Accolsero anche alcune divinità greche fra cui Ercole e Persefone simbolo della vegetazione rifiorente. La tavoletta votiva di Agnone del sec. III a.C. rinvenuta circa un secolo fa, rivelò tutto un elenco di divinità campestri adorate dai Sanniti. Ma loro dio nazionale era pur sempre Mavors, al quale come protettore della stirpe e della sua prosperità, si dedicava uno speciale culto.
Ricchi i vestiti delle donne sannite indossati nelle cerimonie religiose e civili e nelle feste e sappiamo che le matrone romane non disdegnavano di imitarli.
Gli scavi di Pompei e di Ercolano hanno poi messo in luce, la luminosa casa sannita e quelli di Capua e di Pesto, i loro dipinti del V secolo, il secolo dell’occupazione della Campania, nei quali, come nelle più tarde tombe di Alife, si appalesa una robusta arte indigena, troncata nel suo sicuro sviluppo, dalle vittorie romane. Un caratteristico rito regolava, infine, il matrimonio, affidato a un pubblico magistrato che in un determinato giorno dell’anno, concedeva in una solenne cerimonia e in ordine di precedenza, il diritto di scelta della sposa ai giovani meritevoli. Ecco un’ideale descrizione del rito che il grande molisano Vincenzo Cuoco, ci ha lasciato, rito, che premia la virtù con i doni dell’amore:
«Tutto il Sannio è raccolto. Nel mezzo vedi le vittime, i vasi, gli arredi sacri; intorno sacerdoti e ministri del Tempio. Prossimi ai medesimi sono i giudici e le vergini che devono essere spose. Tu le vedi vestite di bianco ed hanno sulla fronte una corona di rose schiuse nella notte; il rito sacro esige che esse non abbiano visto altro sole, onde esprimano più veracemente l’innocenza e la purità. Le madri sono ornate di porpora. Dall’altro lato, vedi i giovani, armati, ma quelle loro armi sono spoglie dei nemici vinti. In un giorno di tanta pompa, non vedi né oro, né argento, né gemme: la religione li vieta come cose che rendono servo il valore e venale l’amore. Le trombe sacre suonano. Tutto il popolo si muove in ordine, per la solenne processione verso il tempio della dea. Precedono quei giovanetti che ancora non possono trattare le armi e seguono la statua di Marte; muovono ultimi, accompagnando la statua della Vittoria, quelli che l’hanno resa propizia al popolo, col sacrifizio dei loro anni più belli. Compiuti i sacrifizi, tutto il popolo si dispone in un immenso anfiteatro. Al suono di maestosa musica militare, si avanzano i duci aventi in mano il registro dei nomi di quei prodi, che sotto i loro stessi occhi hanno ben meritato dalla patria. Il banditore ne proclama i nomi ed ecco il suolo coprirsi di un nembo di fiori.
Ciascuno dei giovani ha già gettato la propria ghirlanda alla prescelta. L’arena rimbomba dei nomi dei vincitori e delle loro spose, l’eco li ripete fin negli antri del vicino Matese. I fanciulli e le fanciulle intonano il canto dell’imeneo: divisi in due cori, cantano un canto alterno e il loro canto ha sembianza di guerra.
Era questo il popolo che Roma doveva combattere e vincere, solo dopo quasi settanta anni di lotta; il pericoloso nemico che per territorio (ventimila chilometri quadrati, contro settemila) e per popolazione, sbarrava il cammino alla Lega romano-latina, anch’essa in via di espansione.
In tempi lontanissimi e che nessuna indagine potrà mai precisare, agricoltori e pastori si fermarono presso la confluenza del Sabato e del Calore. I due fiumi erano necessari ai bisogni agricoli, ai raduni delle greggi. Dove era l’estremo lembo occidentale di Benevento, sorsero le prime capanne, il primo centro abitato; dove ora corre la vaporiera, si allargavano i recinti per i mugghianti buoi. Dalle valli e dalle pianure, ampio respiro verde per i pascoli invernali dovettero allora salire o allacciarsi faticosamente, le strade per l’Apulia, verso le stazioni del Matese, verso l’Alto Sannio, dalle quali discesero poi le greggi per il pascolo e la tosatura.
Dalla voce greca mallos, vello di pecora e dal suffisso collettivo enton, Maloenton e latinamente Maleventum, ebbe il suo nome.
Località, dunque, di pastori, di baratto e commercio della lana. La piana tra i due fiumi dovette veder fiorire un intenso mercato che darà origine alla futura floridezza della Città. Vi giungevano, attraverso l’Apulia, mercanti fenici e greci che sfidavano sulle navi onerarie e non appena le Pleiadi apparivano dolci nell’azzurra notte, i disagi della lunga navigazione. Portavano le stoffe, le calzature, le pelli già confezionate, i non comuni vasellami, gli unguenti e i profumi per i riti sacri e mortuarii, gli ornamenti femminili, e partecipavano ai banchetti, dopo i proficui contratti, col vino che Ulisse prodigò al Ciclope orrendo. E nelle sere lunghe, nelle pause del ritorno, i mercanti ionii di Coo e di Rodi, narravano fascinosi racconti di eroi invincibili; di una lunga guerra combattuta per la
più bella donna dell’Ellade; di strani paesi abitati da mostri e da giganti; e di sirene dal canto melodioso e ingannatore e di vendette di dei corrucciati.
Narravano di un lungo viaggio compiuto da audaci navigatori alla ricerca del vello d’oro e la scia della nave che li portava, divenuta voce melodiosa per opera del divin Orfeo; e sopra tutto raccontavano del figlio di Tidéo, il forte Diomede domatore di selvaggi cavalli. E dicevano che Diomede era poi approdato in Italia, in alcune isole fiorenti fra dolci onde azzurrine, e con la sua gente era disceso, dopo aver vinto e soggiogato il paese dei Dauni, verso le popolazioni osche, per fondare Maloenton.
Ebbe così vita, nella realtà e nella parola, una delle città che con Boviano, Isernia e Aquilonia, doveva segnare i fasti e i rovesci della dominazione sannita. E su questi ultimi, influì senza dubbio lo spirito di autonomia che come nella confederazione etrusca, dominava l’organismo sannita, tanto diverso pertanto, dalla concezione romana: conciliare nello stato la vita delle città. Quella che fu chiamata forza e debolezza dello Stato Sannita, consisterà – è vero – nell’assenza di dominatori e di dominati, nello scarso numero di proletari e di schiavi, ma dannosa appariva l’autonomia delle tribù, debole di conseguenza, il potere centrale e l’autorità del meddix tuticus, supremo magistrato federale; inceppato o incoerente quindi, l’impiego delle forze per sostenere una lunga guerra. Non devono, pertanto, sorprendere le vittorie romane, se mai sorprende la durata dell’aspra lotta vinta sopra tutto dall’organizzazione offensiva di Roma, che lentamente, nel cerchio delle sue colonie, imprigionò e soffocò la resistenza del Sannio. Aspra lotta, perché la conquista integrale e definitiva della Campania da parte sannita, avrebbe portato all’egemonia del Sannio e al suo predominio commerciale nella Magna Grecia e quindi all’arresto dell’espansione romano-latina. Non è del mio tema, trattare della lunga guerra su cui la Storia esercita la sua assidua critica. Dirò piuttosto, che la sannita Maloentum, transito diremo obbligato, tra la Campania e l’Apulia, apparve ben presto, nel programma offensivo di Roma, come un ostacolo da superare. Fu, pertanto, sulla via di Benevento, che Roma doveva consolidare lo sviluppo della sua potenza. Questo piano, è noto, venne perseguito con tenacia ma non senza insuccessi, e il più grande, fu certo il disastro romano alle Forche Caudine. Fosca pagina e non la sola, durante questa lotta e sulla quale si indugia con scultorea obbiettività lo storico romano; pittoresco il paesaggio su cui si posò l’onta della resa; dolci le ondulazioni dei colli, la valle irrigua e boscosa, il panorama fiabesco.
La sconfitta di Caudio, legata al nome del duce sannita Ponzio Telesino, non fu tuttavia per i Romani e da un altro punto di vista, una sconfitta, se pensiamo agli insegnamenti che ne scaturirono e che li indussero, fra l’altro, a nuovi accorgimenti nella tattica e nell’ordinamento dell’esercito e a modificare le armi sull’esempio del nemico. Con i manipoli, con le nuove armi, con la riforma della cavalleria, Roma si preparò alla rivincita. Il patto caudino fu, pertanto, una sosta che se mai serve a dimostrare la piena efficienza degli avversari, sosta che permise a Roma altri tentativi verso l’Apulia, attraverso l’Appennino e lungo l’Adriatico. E fu allora, che i Sanniti alla nuova minaccia, con prontezza ed intuito degni di un popolo forte, mossero sul Liri per occupare a loro volta, le due vie del Lazio e tagliare Roma fuori della Campania. Il passo di Lautule «queste Termopili d’Italia» – è stato detto – tra i monti e il lago di Fondi, l’esercito romano piegò ancora una volta. Questa battaglia alla quale i confederati pentro-irpini-caudini dettero il loro migliore contributo, segnò il culmine dei successi sanniti. Ma la mirabile unità romana doveva prendere ben presto il sopravvento.
Non è sempre possibile tener dietro con rigore storico allo svolgersi degli avvenimenti che seguirono. Nelle tumultuose pagine dello storico latino, prorompe con affannoso rigurgito di episodi. Scontri offensivi e difensivi s’incalzano e si moltiplicano. E’ la coraggiosa fine di un popolo che si annunzia.
Dai monti selvosi del Sannio, dai boschi sacri, il vecchio dio nazionale, ritorna invocato nelle ultime battaglie. Le ritorte buccine invitano ancora alla riscossa i popoli italici nemici di Roma. Invano la dolce primavera è discesa nelle valli fiorite del Sannio. Il banditore non chiama quell’anno, innanzi al magistrato i giovani meritevoli, per le sospirate nozze. Il suolo – secondo il rito – non fu cosparso dalle corone di rose schiuse nella notte, perché un solo mattino le vedesse; non rise al sole la felice giovinezza sannita. Risposero all’appello, Etruschi, Galli e Umbri. La battaglia di Sentino pose fine allo sforzo eroico e disperato. Dopo, la guerra durò ancora quattro anni, ma fu guerra, venne anche detto, per il solo onore del popolo sannita. L’annalistica romana appare quasi solenne innanzi a quel vivido destino. Tutto l’esercito, l’ultimo grande sforzo del Sannio, si era concentrato ad Aquilonia. Nel mezzo del campo il gran sacerdote, Orio Paccio, iniziò il rito, leggendo le formule dell’antica religione sannita. L’embratur condusse allora, innanzi all’altare i guerrieri, perché invocassero più che l’aiuto degli dei, la loro diretta partecipazione all’estremo conflitto, perché essi fossero congiunti agli estremi destini della patria.
Pronunziarono poi, la formula della maledizione su se stessi, sulle famiglie, sui beni e sulla stirpe, ove fuggissero davanti al nemico o lasciassero in vita un disertore.
Sedicimila giurarono con a capo gli optimates e tutto il fiore della nobiltà del Sannio, splendette ancora una volta nella battaglia, con i suoi manti scarlatti, con le armi ageminate d’oro e d’argento, con i suoi elmi piumati, col suo eroico e sventurato coraggio. Ma gli dei antichi della patria sannita non intervennero, e quelli di Roma, erano accanto ai discendenti di Romolo e sui loro bianchi cavalli, erano tornati i giovani dioscuri, gli dei che sul lago Regillo 50 anni innanzi, avevano dato a Roma, la prima grande vittoria.
Sulla nobile fine politica di questo popolo italico, doveva levarsi scultoreo l’elogio del grande storico romano, unico grande elogio concesso da Roma al popolo vinto. «Ben si procacciarono i Sanniti – egli dice – non una grande, ma una perpetua vittoria. Poiché essi non avevano presa Roma come già i Galli, ma quello che era molto piùù difficile e glorioso, la virtus e la fierezza romana».
Ma un’ultima pagina della sua storia il Sannio doveva scriverla durante le guerre civili che coprirono Roma e l’Italia di stragi e di rovine. L’emblema sannita doveva ancora una volta apparire quando passò sulla Penisola la spietata mano di Silla. “Bruciamo la terra che ci nega la cittadinanza italica” aveva esclamato – strano ricorso di nomi – un altro duce sannita, Ponzio Telesino. Balzò dal conio, la medaglia col toro egemonico che squarcia la lupa di Roma, e fu allora che Corfinio, centro dell’insurrezione, mutò il suo nome in Viteliu, donde Italia, fatale nome unificatore che Cesare porterà fino alle Alpi, dal Varo a Trieste e Dante fisserà nei suoi confini, nel poema immortale.
Su Roma, audacemente, giungevano in quell’82 a.C. i Sanniti, sopraffacendo le forze del pretore Appio Claudio. Ma la battaglia decisiva fu combattuta al sopraggiungere di Silla. In quel brumoso novembre, l’estrema lotta che oramai sfiorava tre secoli, finiva innanzi alla Città eterna con la vittoria del Dittattore che non perdonò al fiero popolo sannita. Sulla spietata sua Vendetta doveva levarsi più tardi, la voce di uno scrittore del tempo dell’imperatore Adriano, che si chiese dove fosse possibile trovare il Sannio nel Sannio. Il gallo di bronzo, l’insegna dei manipoli sanniti non doveva più ricomparire.
Silla aveva pur detto che finché il nome sannita non fosse spento, nessun Romano poteva vivere sicuro di sé; ma le città sannite gravitando nell’orbita di Roma, dettero il loro contributo e la loro vitalità alla sua fatale grandezza.
E fra esse, Maleventum che vide sui suoi colli nel 275 a.C., la ritirata del geniale e non fortunato re Pirro, ritirata che prenunziava la non lontana fine dell’ellenismo politico nell’Italia meridionale, già iniziato due secoli innanzi, per opera sannita. E poi in questo periodo di decisivi avvenimenti per l’unificazione della Penisola, che Maleventum mutò il suo, nome che era sembrato maleaugurante ai superstiziosi Romani, in quello augurale di Beneventum.
Nel 268 a.C., insieme con Rimini, diventava colonia latina per separare gli Irpini dai Pentri, colonia che doveva ampliarsi nel 42 a.C. con la deduzione dei veterani di Cesare e infine, rinnovarsi con Augusto col titolo di lulia, Concordia, Augusta, Felix, Beneventum. E fu verso la metà del II secolo che doveva raggiungere l’apogeo della sua importanza, della sua floridezza. La via Traiana, dovuta al genio politico e militare del grande imperatore che volle con quella via, nello sviluppo della sua politica orientale, meglio allacciare l’Oriente a Roma, abbreviandone il percorso fino a Brindisi, dette a Benevento un indubbio primato.
Consolari, magistrati, insigniti di alti gradi militari, letterati, officine scrittorie, sodalizi e una fiorente attività nel campo economico, artistico e industriale del tempo, la resero illustre e fastosa, alacre e piena di movimento, per il cosmopolitismo che le veniva dai transiti con l’Oriente. Nel secolo V d.C., Benevento già inclusa dall’imperatore Adriano nella Campania, ritorna alla regione Samnium. E sembrò fatale ritorno, mentre l’impero crollava, questa estrema assegnazione della Città alla regione di origine del secolo V a.C., assegnazione che chiudeva col nome sannita, dieci secoli di storia e con essi il tramonto di due civiltà, dalle quali nasceva il Medio Evo.
Perché il Sannio non ebbe solo l’ardimento e la gloria di combattere Roma, ma ebbe soprattutto il vanto di preparare la gloria di Roma, contribuendo a porre le vere basi di quell’impero che fu luce di civiltà per i popoli.
Pur devastato e sconvolto, esso rimase nei suoi antichi confini geografici; nella ripartizione regionale di Augusto, tale anche nel periodo barbarico e certamente fino al secolo X. Solo le vicende posteriori a quel periodo, ne poterono oscurare il nome. Così il Molise finì per avere una sua vita autonoma; il Sannio Caudino rimase privo del suo centro vitale, Benevento, divenuta possesso della Santa Sede. Il resto della Regione Irpino-Caudina gravitò intorno a nuovi centri, ma pur sempre il Sannio non sconfinò dai suoi limiti antichi che caratteristiche fisiche, razziali, storiche e archeologiche rendono pur sempre omogeneo.
E tale infine, si rivelò nei periodi fondamentali della vita politica italiana, dal Medio Evo al Risorgimento. Dal Sannio doveva partire l’equilibrato pensiero politico sulla rivoluzione del 1799; e nel 1820, l’affermarsi delle libertà costituzionali, dal Sannio nel 1848, il primo consapevole grido unitario nazionale; dal Sannio infine, gli italiani di pensiero e di azione, da Vincenzo Cuoco a Gabriele Pepe, da Lorenzo de Concili a Federico Torre a Giuseppe de Marco la voce della libertà, della riscossa, dell’indipendenza e dell’unità della Patria. Voce che ci consente oggi, a un secolo di distanza di salutare l’Italia nella eroica fede dei nostri padri.
Napoli, Circolo Sannita, Conferenza del 12-XII-1960.
ALFREDO ZAZO
